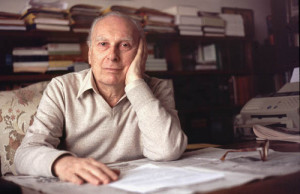L’articolo che segue è un estratto della tesi di laurea dal titolo “Una memoria divisa”. La controversa figura di Rodolfo Graziani tra politica repressiva e crimini di guerra in Etiopia, presentata all’Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS) di Pavia lo scorso maggio.
Parte terza
Nessun processo
Subito dopo la guerra, a carico di Graziani furono avviate indagini per la sua attività svolta durante la Repubblica Sociale Italiana. Già il 14 giugno del ’45, infatti, l’ex ministro della difesa della RSI, assieme agli ex generali di corpo d’armata Gastone Gambara e Archimede Mischi, era stato denunciato dal ministro della guerra Alessandro Casati all’autorità giudiziaria militare per il reato contemplato dall’articolo 51 del codice penale militare di guerra, il quale prevedeva la pena di morte e la degradazione per il militare che avesse commesso un fatto «diretto a favorire le operazioni militari del nemico o a nuocere altrimenti alle operazioni delle forze armate dello Stato italiano1».
Inoltre, nel maggio dell’anno precedente, si era mosso contro Graziani anche l’Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo, il quale aveva deferito il maresciallo all’Alta corte di giustizia e contemporaneamente aveva emesso un mandato di cattura contro di lui.
Il dibattimento ebbe inizio solo l’11 ottobre del ’48, con la formulazione del seguente capo d’accusa:
Rodolfo Graziani, nato a Filettino (Frosinone) l’11 agosto del 1882, è imputato del reato di collaborazionismo militare per avere, dopo l’8 settembre del 1943 e fino al maggio 1945 in Roma e nei territori dell’Italia del Nord commesso delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato, collaborando con il tedesco invasore, e ciò col farsi animatore, organizzatore e capo dell’esercito dei rinnegati e traditori al soldo del governo fascista repubblicano e con l’assumere la carica di ministro per la Difesa nazionale dello stesso governo, emanando in tale qualità ordini di rastrellamento e bandi, con minaccia di pene terroristiche, disponendo rastrellamenti sistematici, reprimendo con le armi ogni attività dei patrioti contro i tedeschi, facendo così affrontare dalle truppe da lui comandate, sino alla disfatta, i combattimenti di una guerra fratricida contro gli italiani2.
L’anno seguente i giudici del Tribunale militare di Roma, a cui era stato rimesso il giudizio, condannarono finalmente Graziani a diciannove anni di carcere, con il condono di tredici anni e otto mesi. Tuttavia, grazie ad un’eccezione procedurale avanzata dalla difesa, soltanto quattro mesi dopo, il 29 agosto del 1950, Graziani potè ritornare in libertà.
Se per la sua attività al servizio della Repubblica Sociale Italiana, Graziani era stato quantomeno sottoposto a processo e condannato dal Tribunale militare di Roma, pur scontando alla fine una pena pressoché irrisoria, per quanto riguarda i crimini di guerra che aveva commesso in Libia e in Etiopia, invece, non vi fu, da parte della giustizia italiana, alcuna condanna e nemmeno un tentativo di far luce sulla vicenda. Per quali motivi?
Rispetto alla questione dei criminali di guerra italiani, l’articolo 29 del Long Armistice, firmato a Malta il 29 settembre del 1943, aveva stabilito che:
Benito Mussolini, i suoi principali associati fascisti e tutte le persone sospette di aver commesso delitti di guerra o reati analoghi, i cui nomi si trovano sugli elenchi che verranno comunicati dalle Forze Alleate e che ora o in avvenire si trovino in territorio controllato dal Comando Militare Alleato o dal Governo Italiano, saranno immediatamente arrestati e consegnati agli Alleati. Tutti gli ordini impartiti dalle Forze Alleate a questo riguardo verranno osservati3.
In generale, però, nonostante questa disposizione, al termine della Seconda guerra mondiale, nel momento in cui le vittime si aspettavano che venisse fatta finalmente giustizia, un velo di impunità calò sull’operato di quasi tutti gli italiani che si erano resi responsabili di atrocità in Africa e nei Balcani.
La questione della punizione dei crimini di guerra italiani in Etiopia è molto complessa e seguì per certi versi logiche e percorsi differenti rispetto a quanto avvenuto per i criminali di guerra che avevano commesso efferatezze analoghe nei Balcani contro i partigiani jugoslavi o su suolo italiano contro prigionieri di guerra anglo-americani4.
Va innanzitutto precisato che il concetto di “crimine di guerra” fu introdotto solo nel 1943, grazie ai lavori della Commissione delle Nazioni Unite per i crimini di guerra (United Nations War Crimes Commission, UNWCC5), un organismo di carattere internazionale, creato allo scopo di ricevere le liste dei presunti criminali di guerra dai parte dei paesi vittime, per analizzarle e disporre, laddove necessario, le estradizioni.
Il concetto è quindi posteriore, in senso cronologico, alla guerra d’Etiopia, sebbene la sua applicazione al caso possa essere ritenuta corretta in quanto nel 1947 l’Etiopia fu autorizzata a redigere una propria lista di criminali di guerra italiani e la UNWCC riconobbe effettivamente questi ultimi come tali (stessa cosa era accaduta, tempo prima, con i giapponesi che erano stati accusati dalla Cina per crimini di guerra commessi durante l’invasione della Manciuria, nel 1931-’32).
Tuttavia, come vedremo, l’elaborazione della categoria nel contesto della Seconda guerra mondiale influenzò inizialmente in maniera notevole l’orientamento della Commissione rispetto alle richieste di estradizione dei criminali di guerra italiani avanzate a più riprese dall’Etiopia.
Altro aspetto importante da tenere presente nello studio della vicenda è la mancanza di un qualsiasi contatto di tipo diplomatico tra Italia ed Etiopia, il che rese di fatto impossibile un confronto diretto tra i due paesi6.
Infine, non si può assolutamente trascurare il ruolo esercitato dagli Alleati, in particolare dalla Gran Bretagna, nella gestione della vicenda. Comprendere le ragioni che presiedettero alle scelte del governo britannico rispetto alla questione dei criminali di guerra italiani è fondamentale per capire l’evolversi dei fatti.
Richard Pankhurst, in un importante saggio del 1999, ha ricostruito l’evoluzione del dibattito internazionale sui crimini di guerra in Etiopia, dal 1936 al ’49, nel tentativo di capire perché gli sforzi fatti dal governo imperiale etiopico di processare i criminali di guerra italiani fallirono7.
Pankhurst ha osservato che la questione dei crimini di guerra fascisti fu sollevata dal governo etiopico in circostanze e tempi molto diversi. Dapprima, venne posta all’attenzione della Società delle Nazioni (SdN), mentre si stavano perpetrando i crimini, poi, a quella della Commissione delle Nazioni Unite per i crimini di guerra, circa mezzo decennio dopo. In nessuna delle due occasioni, però, l’iniziativa etiopica ebbe successo. Per quali motivi?
La Società delle Nazioni, sebbene avesse applicato sanzioni economiche all’Italia per l’aggressione all’Etiopia, tuttavia non fece nulla di concreto per frenare l’invasione, principalmente perché Gran Bretagna e Francia, i due membri principali dell’organizzazione, intendevano evitare che l’Italia si avvicinasse alla Germania e, quindi, preferirono assecondare di fatto il progetto espansionistico di Mussolini, piuttosto che condannare le atrocità che le forze italiane stavano commettendo.
La Commissione delle Nazioni Unite per i crimini di guerra, invece, benché creata proprio allo scopo di processare i criminali di guerra e interpretare i nuovi indirizzi internazionali, tuttavia non dimostrò maggiore interesse della Società delle Nazioni a condannare i crimini di guerra perpetrati in Etiopia, sostanzialmente perché la Gran Bretagna, che aveva un interesse limitato nei confronti dei crimini commessi verso cittadini non-europei, aveva riconosciuto nel 1938 la conquista dell’Etiopia da parte di Mussolini e non voleva riconsiderare le modalità con cui questo obiettivo era stato raggiunto.
Inoltre, gli inglesi erano contrari a far processare Badoglio, ritenuto dal governo imperiale etiopico il più importante criminale di guerra italiano. Infatti, sebbene fosse ampiamente noto ai britannici l’impiego da parte sua dei gas tossici in Etiopia, tuttavia, dopo l’8 settembre, il maresciallo iniziò ad essere considerato dagli anglo-americani come un personaggio politico chiave, da sfruttare nella complessa e incerta situazione italiana:
L’opinione degli Alleati subì un importante cambiamento nell’estate del 1943 […] Gli americani e gli inglesi cominciarono a pensare che il maresciallo Badoglio fosse un uomo con cui avrebbero potuto collaborare. Sebbene egli avesse fatto uso di gas in Etiopia, tuttavia essi non lo consideravano un criminale di guerra, ma una forza per la stabilità europea8.
L’argomentazione principale contro l’estradizione dei criminali di guerra italiani fu formulata dal dipartimento degli esteri britannico, il Foreign Office, e consistette nel sostenere che la guerra italo-etiopica del 1935-’36, benché fosse stata accompagnata da numerose atrocità fasciste, non avesse avuto alcuna relazione con la guerra europea, cominciata nel settembre del ’39, e per la quale la Commissione delle Nazioni Unite per i crimini di guerra era stata creata.
Alcuni parlamentari inglesi, ad esempio il laburista Emanuel Shinwell9, sollevarono delle obiezioni in proposito, osservando che, dato l’impiego dei gas tossici da parte degli italiani contro gli abissini, evidentemente sarebbe stato un atto di giustizia consegnare i criminali di guerra italiani all’Etiopia10.
Alla fine, però, sotto le pressioni del governo, la commissione accettò di circoscrivere i propri lavori agli anni della Seconda guerra mondiale, escludendo dalle indagini i crimini di guerra che erano stati commessi precedentemente in Etiopia.
La questione continuò comunque ad agitare le acque: infatti, nel mese di aprile del 1945 il New Times and Ethiopia News a Londra pubblicò un importante pamphlet dal titolo Italy’s War Crimes in Ethiopia, il quale conteneva estratti dei resoconti dei massacri di Graziani e alcune fotografie delle esecuzioni, scattate dai fascisti stessi e rinvenute dopo la liberazione da parte britannica del paese. Il documento ebbe un’ampia diffusione, tanto da essere poco tempo dopo ristampato.
Al termine del conflitto, la questione divenne fortemente dibattuta. Il 20 giugno il Foreign Office redasse una “Biografia di Graziani”, in cui si osservava che il massacro di Addis Abeba era associato al suo nome: si leggeva, per esempio, che «parecchie migliaia di abissini, uomini, donne e bambini furono massacrati» e che «camicie nere, armate con fucili, pistole, bombe e lanciafiamme si scagliarono sulla popolazione locale e un tremendo massacro fu portato avanti per tre giorni11».
Il 3 ottobre dello stesso anno il governo etiopico annunciò la decisione di aderire al Patto di Londra (London Agreement) per il procedimento e la punizione dei maggiori criminali di guerra dell’Asse e il 20 maggio dell’anno seguente fu nominata per ordine del governo imperiale una commissione etiope per i crimini di guerra.
Successivamente, durante le negoziazioni per il trattato di pace con l’Italia12, il governo etiopico riuscì a far incorporare nel testo finale l’importante principio in base al quale la Seconda guerra mondiale, per l’Etiopia, era cominciata il 3 ottobre del 1935. L’articolo 38 stabiliva infatti che:
La data, a decorrere dalla quale le disposizioni del presente Trattato diverranno applicabili, per quanto riguarda le misure e gli atti di qualsiasi natura che comportino responsabilità per l’Italia o per i cittadini italiani nei riguardi dell’Etiopia, s’intenderà fissata al 3 ottobre 1935.13.
Tale articolo si applicava alla questione dei crimini di guerra, regolata dall’articolo 45, in base al quale l’Italia avrebbe preso «tutte le sue misure necessarie per assicurare l’arresto e la consegna al fine di un successivo giudizio» delle persone «accusate di aver commesso, ordinato o favorito crimini di guerra e crimini contro la pace o l’umanità» e «dei sudditi delle potenze alleate od associate, accusati di aver violato le leggi del proprio paese, per aver commesso atti di tradimento o di collaborazione con il nemico durante la guerra» (paragrafo 1); avrebbe analogamente, «su richiesta dei governi delle Nazioni Unite coinvolti», resi «disponibili come testimoni» le persone la cui testimonianza si rendeva «necessaria per il processo delle persone di cui al paragrafo 1 di questo articolo» (paragrafo 2); infine, «qualsiasi disaccordo concernente l’applicazione dei paragrafi 1 e 2 di tale articolo» sarebbe stato riportato «da qualunque dei governi coinvolti agli ambasciatori a Roma dell’Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d’America e della Francia», i quali avrebbero raggiunto «un accordo per superare il problema» (paragrafo 3)14.
La posizione dell’Etiopia sembrò ulteriormente rafforzata dall’articolo 56, il quale dispose che gli ambasciatori delle quattro grandi potenze a Roma, «agendo di concerto», avrebbero «rappresentato gli Alleati e le potenze associate in tutte le questioni concernenti l’esecuzione e l’interpretazione del presente trattato15».
La Commissione delle Nazioni Unite per i crimini di guerra, però, fu molto lenta nel recepire questi principi: solo il 29 ottobre del ’47, a oltre sette mesi di distanza dalla firma del Trattato di Pace, essa accettò di considerare i crimini di guerra commessi in Etiopia a partire dal 3 ottobre del 1935.
Il governo imperiale etiopico, d’altra parte, si trovò di fronte a una serie di difficoltà nella preparazione delle liste dei criminali di guerra: 1) lo scarso tempo a disposizione (la Commissione, infatti, avrebbe chiuso i battenti il 31 marzo del 1948); 2) la pressoché quasi impossibilità di reperire prove dal valore legale, dal momento che la maggior parte dei crimini di guerra italiani erano stati commessi quando il governo etiopico stava collassando o dopo che era già caduto; 3) la mancanza di personale qualificato nelle ricerche, visto che lo stato etiopico era stato restaurato solo nel 1941.
Nonostante questi limiti, il governo imperiale riuscì in poche settimane a redigere una lista dettagliata di accuse contro cinquanta sospetti criminali di guerra, tra i quali venne individuata una rosa di dieci nomi da inviare alla Commissione, al fine di ottenerne l’estradizione. Significativamente, il nome di Graziani figurava al secondo posto, subito dopo quello di Badoglio:
-
Pietro Badoglio, comandante supremo delle forze italiane in Africa Orientale;
-
Rodolfo Graziani, comandante delle forze italiane in Somalia, governatore generale dell’Africa Orientale Italiana, vicerè d’Etiopia;
-
Alessandro Lessona, segretario di Stato italiano per le colonie;
-
Guido Cortese, segretario federale del Partito Nazionale Fascista ad Addis Abeba;
-
Guglielmo Nasi, governatore italiano dell’Harar;
-
Alessandro Pirzio Biroli, governatore italiano dell’Amara;
-
Carlo Geloso, governatore italiano di Galla e Sidama;
-
Sebastiano Gallina, generale;
-
Ruggero Tracchia, generale;
-
Enrico Cerulli, capo dell’ufficio politico per l’Africa Orientale presso il Ministero italiano degli Affari Esteri, Direttore generale degli affari politici, vice-governatore generale dell’Africa Orientale Italiana.
Una volta ricevuta la lista, la Commissione aprì nella sua ultima seduta del 4 marzo i lavori, confermando definitivamente che, di quei dieci, otto erano da considerarsi criminali di guerra e due testimoni.
Badoglio fu ritenuto colpevole «per l’utilizzo di gas tossici e per il bombardamento degli ospedali e delle ambulanze della Croce Rossa16».
Quanto a Graziani, il Barone Erik Leijonhufvud, rappresentante dell’Etiopia nella Commissione, dichiarò, che «uno studio minuzioso» del suo caso poteva certamente fornire «una spiegazione dell’intera politica italiana di sistematico terrorismo». In supporto a questa tesi addusse come prove la frase, prunciata dallo stesso Graziani, di «voler condannare a morte tutti gli Amhara», e il telegramma indirizzato al generale Nasi, in cui aveva scritto: «ricordati anche che io ho aspirato alla totale distruzione dei capi e dei notabili abissini e che questo dovrebbe essere realizzato compiutamente anche nei territori sotto il tuo controllo17».
In base alla documentazione presentata, Graziani venne accusato di: omicidio di massa; saccheggio, a causa della devastazione sistematica di Addis Abeba, nel febbraio del 1937, e successivamente del monastero di Debrà Libanòs; bombardamento deliberato delle unità della Croce Rossa.
L’estradizione dei due personaggi, ritenuti i più grandi criminali di guerra italiani, tuttavia, fu ostacolata nuovamente per il fatto che l’Etiopia e l’Italia non avevano ancora ristabilito le relazioni diplomatiche e anche per il fatto che il governo britannico non intendeva agire da intermediario nella questione, temendo un danneggiamento dei rapporti con l’Italia. Come osservò un funzionario del Foreign Office, Francis Brown
[…] abbiamo deciso che la questione debba essere sistemata direttamente tra il governo etiopico e quello italiano […]
Riconosco che in passato abbiamo agito, su questioni minori, da intermediari tra i due governi. Nella circostanza presente, tuttavia, penso che sarebbe estremamente poco saggio comportarci da intermediari, dal momento che gli italiani penserebbero inevitabilmente che stiamo supportando le richieste dell’Etiopia, e questo sopraggiungerebbe in un momento particolarmente sfavorevole, quando la questione dell’Eritrea sta ancora facendo discutere Inghilterra e Italia18.
Venuta meno qualsiasi possibilità di intermediazione da parte della Gran Bretagna, il governo etiopico cercò un approccio diretto col governo italiano, cercando di superare l’impasse rappresentato dalla mancanza di relazioni diplomatiche trasmettendo, per mezzo dell’ambasciatore etiope a Londra, un memorandum all’ambasciatore italiano, che, tuttavia, rifiutò di prendere visione del documento.
I tentativi etiopici di ottenere giustizia continuarono fino al 1949 ma, date le ostilità del governo italiano e inglese, oltre alla pressione del Foreign Office – il cui supporto il governo etiopico riteneva vitale per la rivendicazione dell’Eritrea19 – alla fine furono abbandonati.
Secondo Pankhurst il fallimento delle richieste avanzate dall’Etiopia non fu dovuto alla debolezza della accuse presentate, ma alla tenace opposizione italiana e ai pregiudizi degli alleati dell’Etiopia:
L’Italia del dopoguerra non voleva far fronte al fatto che i suoi soldati avevano commesso crimini di guerra in Etiopia […]
I leader europei della comunità internazionale del secondo dopoguerra, per parte loro, erano parimenti impreparati a vedere gli alleati europei puniti per crimini commessi contro non europei quasi mezzo decennio prima e preferirono un errore giudiziario20.
Diversamente da quanto accaduto per i criminali di guerra richiesti dai paesi dei Balcani, per esempio la ex-Jugoslavia, per i quali venne prevista l’istituzione di una Commissione d’Inchiesta italiana che indagasse sul loro conto e deferisse i colpevoli al Tribunale militare21, Badoglio, Graziani e tutti gli altri che avevano commesso crimini di guerra in Etiopia non furono mai chiamati a rendere conto dei loro atti.
Su quei crimini, compiuti durante la guerra per l’impero, calò un silenzio che si protrasse per molti anni: silenzio che, da un lato, favorì l’affermazione di una percezione di impunità, esemplificata dal successo del mito degli «italiani brava gente» e, dall’altro, impedì un serio dibattito sul passato coloniale del nostro paese.
La polemica sull’utilizzo dei gas e il mito degli «italiani brava gente»
La memoria dei crimini di guerra italiani in Africa è una memoria che è stata per lungo tempo “divisa”. Segnale eloquente di tale spaccatura è stata la celeberrima polemica sull’impiego dei gas in Etiopia scoppiata negli anni Sessanta tra lo storico Del Boca e il giornalista Montanelli. Semplicemente non era vero, secondo quest’ultimo, quello che diceva Del Boca sulla guerra in Abissinia, e cioè che l’Esercito italiano avesse sperimentato su larga scala gas tossici sulla popolazione locale per fiaccarne la resistenza e concludere più celermente il conflitto. Quella tesi, che appariva sconcertante e soprattutto scomoda, fu osteggiata per lungo tempo, fino a che nel 1996 uscì un importantissimo volumetto, pubblicato da Del Boca, in collaborazione con Giorgio Rochat, Ferdinando Pedriali e Roberto Gentilli, e intitolato eloquentemente I gas di Mussolini, che per la prima volta forniva una ricostruzione e un bilancio rigorosamente scientifici della guerra chimica scatenata dal fascismo in Etiopia22.
Il primo contributo, dal titolo “Una lunga battaglia per la verità”, firmato da Del Boca, metteva in evidenza gli ostacoli incontrati dallo studioso, specialmente negli anni ’60 e ’70, nel corso delle sue ricerche sul colonialismo italiano: le difficoltà nell’accedere agli archivi storici di importanza nazionale, le reazioni emotive di una parte della stampa italiana alle sue pubblicazioni e, in generale, le critiche ricevute, talvolta sfociate in vere e proprie aggressioni e minacce.
Il secondo saggio, “L’impiego dei gas nella guerra d’Etiopia 1935-1936”, a cura di Rochat, affrontava il problema dell’utilizzo dei gas in Etiopia, evidenziando in primo luogo come la guerra chimica fosse stata considerata dai militari come «un aspetto del tutto normale e scontato della guerra moderna23» e rilevando poi il ruolo predominante dell’aviazione nella conduzione del conflitto, come aveva prospettato il ministro delle Colonie De Bono già nel 1932:
[occorre] una potente aviazione che possa portare il terrore nella capitale e nei principali centri dell’impero, sconvolgere e ritardare la raccolta degli armati nemici, bombardandone e mitragliandone le masse in marcia sulle poche carovaniere o sostanti a cavallo di esse, seminare il panico negli armati e soprattutto nel personale addetto ai servizi, infliggere perdite tali alle varie masse da fiaccarne l’ardore combattivo24.
Pedriali, invece, dedicava il suo saggio dal titolo “Le armi chimiche in Africa Orientale: storia, tecnica, obiettivi, efficacia”, allo studio delle nuove armi, approntate nella primavera-estate del ’35 dall’Ufficio autonomo armamento, in particolare alla fabbricazione e alla sperimentazione della bomba all’iprite C.500.T. Di quest’ultima, partendo da una preziosa seppure incompleta relazione, stesa nel ’53 dall’Ufficio storico dello Stato Maggiore dell’Aeronautica (Sma), venivano analizzate tecnica, obiettivi ed efficacia. Rispetto all’utilizzo dei gas da parte di Graziani, veniva osservato che il maresciallo «ne fu un convinto fautore, facendo lanciare centinaia di tonnellate di bombe C.500.T all’iprite e di nuove bombe C.100.P al fosgene25» e che «alla fine del periodo in cui egli rimase in Etiopia come Vicerè, i quantitavi lanciati si avvicinarono a quelli impiegati contro l’esercito etiopico nella campagna 1935-193626».
Sempre Del Boca raccoglieva poi ne “Le fonti etiopiche e straniere sull’impiego dei gas” le testimonianze delle vittime della guerra chimica: degli etiopici e degli stranieri che stavano dalla loro parte, come medici e giornalisti, ma anche militari. Riportava, per esempio, il racconto di ras Immirù Haile Sellase, uno dei generali più preparati di Hailè Selassié:
Fu uno spettacolo terrificante – racconta il generale – Io stesso sfuggii per un caso alla morte. Era la mattina del 23 dicembre e avevo da poco attraversato il Tacazzè, quando comparvero nel cielo alcuni aeroplani. Il fatto, tuttavia, non ci allarmò troppo, perché ormai ci eravamo abituati ai bombardamenti. Quel mattino, però, non lanciarono bombe, ma strani fusti che si rompevano appena toccavano il suolo o l’acqua del fiume e proiettavano intorno un liquido incolore. Prima che mi potessi rendere conto di ciò che stava accadendo, alcune centinaia fra i miei uomini erano rimasti colpiti dal misterioso liquido e urlavano per il dolore, mentre i loro piedi nudi, le loro mani, i loro volti si coprivano di vesciche. Altri, che si erano dissetati al fiume, si contorcevano a terra in un’agonia che durò ore. Fra i colpiti c’erano anche contadini, che avevano portato le mandrie al fiume, e gente dei villaggi vicini. I miei sottocapi, intanto, mi avevano circondato e mi chiedevano consiglio, ma io ero stordito, non sapevo che cosa rispondere, non sapevo come combattere questa pioggia che bruciava e uccideva27.
Analoga la testimonianza di Marcel Junod, medico della Croce Rossa Internazionale:
Un odore acro mi soffocò. Avvertii anche un pizzicore negli occhi. Non c’erano dubbi, le bombe che cadevano intorno a noi erano bombe all’iprite […] Abiet… Abiet… Abiet. Abbiate pietà… abbiate pietà! Dappertutto, sotto gli alberi, ci sono uomini distesi a terra. Ce ne sono a migliaia. Io mi avvicino, sconvolto. Vedo sui loro piedi, sulle loro membra scarnificate, orribili ustioni che sanguinano. La vita sta già andandosene dai loro corpi corrosi dall’iprite. […] Non ci sono medicine. Le ambulanze sono state distrutte. Non ho alcun mezzo materiale per venire in aiuto a questi infelici28.
Il quinto contributo, “La storiografia aeronautica e il problema dei gas”, a cura di Gentilli, offriva, grazie ad un accurato spoglio dei Diari storici delle Squadriglie, dei Gruppi e degli Stormi impiegati nella guerra d’Etiopia, gli elenchi completi dei bombardamenti a gas, contenenti dati precisi sull’estensione e sull’intensità degli attacchi dal cielo, sia per il fronte Nord, sia per il fronte Sud. Complessivamente, erano state scatenate 202 azioni di guerra29.
Infine, a completamento dell’opera, Del Boca considerava ventisette telegrammi, che Mussolini aveva inviato a Badoglio e a Graziani durante il conflitto italo-etiopico:
Sta bene per azione giorno 29 stop Autorizzato impiego gas come ultima ratio per sopraffare resistenza nemico e in caso di contrattacco.
Dati sistemi nemico di cui a suo dispaccio n°630 autorizzo V. E. all’impiego anche su vasta scala di qualunque gas et dei lanciafiamme.
Approvo pienamente bombardamento rappresaglia et approvo sin da questo momento i successivi. Bisogna soltanto cercare di evitare le istituzioni internazionali croce rossa.
Manovra est bene ideata et riuscirà sicuramente stop Autorizzo V. E. a impiegare tutti i mezzi di guerra dico tutti sia dall’alto come da terra stop. Massima decisione.
Per finirla con i ribelli come nel caso Ancober, impieghi i gas.
Occupata Addis Abeba V. E. darà ordini perché: 1° siano fucilati sommariamente tutti coloro che in città aut dintorni siano sorpresi colle armi alla mano 2° siano fucilati sommariamente tutti i cosiddetti giovani etiopi, barbari crudeli e pretenziosi, autori morali dei saccheggi 3° siano fucilati quanti abbiano partecipato a violenze , saccheggi, incendi 4° siano sommariamente fucilati quanti trascorsi 24 ore non abbiano consegnato armi da fuoco e munizioni. Attendo una parola che confermi che questi ordini saranno – come sempre – eseguiti.
Autorizzo ancora una volta V. E. a iniziare e condurre sistematicamente politica del terrore et dello sterminio contro i ribelli et le popolazioni complici stop. Senza la legge del taglione ad decuplo non si sana la piaga in tempo utile. Attendo conferma30.
La lettura di quei documenti di inestimabile valore portò finalmente nel 1996, dopo una diatriba durata decenni, al riconoscimento da parte del Ministero della Difesa Italiana dell’effettivo utilizzo di aggressivi chimici da parte dell’Esercito Italiano durante la campagna d’Etiopia, in aperta contravvenzione al protocollo di Ginevra del 17 giugno del 192531.
Dopo anni di rimozione di quella triste pagina di storia nazionale, fu così possibile affermare che decine di migliaia di abissini erano stati uccisi dalle bombe caricate all’iprite32, scagliate indistintamente dall’aviazione italiana sui soldati e sulla popolazione locali.
Quella che si configurò sin dall’inizio come una vera e propria guerra d’aggressione, però, non ebbe tra i suoi tratti più cruenti solo l’impiego dei gas: come si evince dai telegrammi, infatti, il Duce ordinò di adottare lo strumento della rappresaglia indiscriminata e di dispiegare con sistematicità una politica di terrore e di sterminio, di cui egli fu principale responsabile e Badoglio e Graziani esecutori. Ha osservato Del Boca, in proposito, che «è indubbio che è sotto la sferza di questi telegrammi tassativi che i generali De Bono, Badoglio e Graziani spinsero avanti abbastanza celermente le loro armate nel vastissimo e accidentato territorio abissino33».
Sebbene costoro e altri, che avevano combattuto in Africa o nei Balcani, fossero stati considerati dei criminali di guerra dalla UNWCC e sebbene la storiografia abbia presentato testimonianze inconfutabili sui loro crimini, come l’utilizzo dei gas in Etiopia, tuttavia ancora oggi permane in buona parte dell’opinione pubblica italiana l’idea che i nostri soldati durante le guerre d’invasione si siano comportati generalmente meglio rispetto ad altre potenze occupanti, ad esempio i tedeschi. Ma non solo: rimane costante l’idea che i soldati italiani siano sempre stati «brava gente», essendo la bontà una caratteristica intrinseca alla loro stirpe, scevra da qualsiasi capacità di compiere realmente del male e, per dirla con Giovanni Messe, capo di Stato Maggiore Generale nel 1943, incapaci di odiare34. Lo studio di questo stereotipo è particolarmente importante, soprattutto alla luce delle conseguenze che tale mito ha prodotto e dell’influenza che esso continua tuttora ad esercitare.
Lo stereotipo degli «italiani brava gente» è stato profusamente studiato negli ultimi due decenni dalla storiografia italiana.
Una delle opere cardine in questo settore è stata quella di Del Boca, Italiani, brava gente?, nella quale lo studioso ha ricostruito la storia dei crimini, in gran parte poco noti, o volutamente taciuti e rimossi, compiuti dalle truppe italiane in Africa, Cina e Balcani. Relativamente all’occupazione africana, Del Boca si è soffermato su alcuni episodi di particolare gravità, come l’internamento nel campo di concentramento di Nocra, le stragi e le deportazioni compiute in Libia, l’utilizzo dell’iprite e la strage di Debrà Libanòs, definita «una soluzione finale», concludendo che il comportamento degli italiani durante l’occupazione necessiti certamente di una severa condanna, la quale è resa più difficile dal ricorso costante ad una sorta di atteggiamento auto-consolatorio:
Anche se incompleto – scrive Del Boca – il quadro che presentiamo dei crimini di guerra compiuti da italiani negli ultimi centocinquant’anni ci sembra tuttavia sufficiente per poter formulare un severo giudizio di condanna. Ciò non vuol dire che gli italiani guidino la classifica delle imprese delittuose. Essi sono però alla pari – certamente secondi ai nazisti – degli altri popoli che, nello stesso periodo di tempo, hanno promosso campagne coloniali e hanno preso parte agli ultimi due conflitti mondiali. Gli italiani, però si differenziano nettamente dagli altri popoli per il continuo ricorso a uno strumento autoconsolatorio, il mito degli «italiani brava gente», che ha coperto, e continua a coprire, tante infamie35.
Un altro lavoro storiografico molto importante in questo ambito è stato quello di Gianni Oliva36, in cui l’autore ha ripercorso le pagine poco note dell’Italia imperiale, soffermandosi sui crimini compiuti dalle truppe d’occupazione italiane nei Balcani, e sullo stereotipo degli “italiani, brava gente”. Secondo Oliva, questo mito è «rassicurante» e «assolutorio», poiché rappresenta il soldato italiano «fondamentalmente buono, saldamente ancorato ai valori della famiglia, persino un po’ “mammone”». Dunque, «egli non è capace di violenza contro gli inermi, non si accanisce nelle rappresaglie, non si abbandona alle violenze brutali della guerra37».
Tale stereotipo ha avuto un’importanza fondamentale nei meccanismi psicologici di “rimozione delle colpe” e di “rielaborazione della memoria nazionale”: «“italiani brava gente”», ha osservato Oliva, «è un tassello centrale nella ricostruzione del passato nazionale, quale va definendosi negli anni compresi tra la caduta del fascismo e la promulgazione della Costituzione repubblicana38».
Ad un’analisi approfondita della genesi e dell’impiego degli stereotipi dei «bravi italiani» e «cattivi tedeschi» è dedicato invece un recente volume di Filippo Focardi39.
Focardi ha individuato, a partire dalla propaganda degli Alleati e poi, dopo l’8 settembre del -43, da quella del re, di Badoglio, e di tutte le forze dell’anti-fascismo, il delinearsi di due tendenze principali. La prima consisteva nel raffronto tra le tipizzazioni del tedesco e dell’italiano, che chiamava in causa una differenza di natura quasi antropologica tra il «tedesco-automa», abituato ad eseguire gli ordini «con brutalità meccanica», e l’italiano sempre pacifico, empatico, cordiale, contrario alla guerra e generoso anche nelle vesti dell’occupante. Questa differenza veniva ulteriormente sottolineata attraverso la contrapposizione fra la figura del «tedesco barbaro incivile» e quella dell’italiano figlio invece della superiore cultura latina e cattolica, capace di moderazione e misericordia verso il prossimo. La seconda tendenza era quella di attribuire esclusivamente ai fascisti la responsabilità dei crimini commessi da parte italiana. Non si doveva parlare, dunque, di «crimini italiani», bensì solo di «crimini fascisti». Questi ultimi, inoltre, erano spesso considerati come frutto di mera «imitazione» di quelli commessi dai tedeschi.
Focardi ha osservato che dopo la guerra, sia le forze della sinistra antifascista, sia gli ambienti monarchici e nazional-conservatori si trovarono concordi nel cementare l’immagine del bravo soldato italiano contrapposta a quella dello spietato guerriero germanico, principalmente poiché condividevano ragioni politiche stringenti: avvicinandosi i negoziati per il trattato di Pace, occorreva separare nella maniera più netta possibile le responsabilità italiane da quelle dell’ex-alleato tedesco, su cui si sperava di scaricare il peso esclusivo dei crimini dell’Asse.
La contrapposizione del comportamento del «bravo italiano» a quello del «cattivo tedesco» costituì, dunque, «uno dei pilastri della strategia difensiva italiana40» e fu sviluppata anche a proposito della questione dei crimini di guerra, in particolare per sostenere il rifiuto italiano all’estradizione dei presunti responsabili.
La memorialistica sulla guerra d’Etiopia
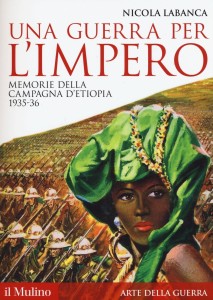
La copertina del libro di Nicola Labanca, “Una guerra per l’impero. Memorie della campagna d’Etiopia 1935-1936”
Una delle fonti storiche più preziose per comprendere l’effettivo svolgimento di una guerra è rappresentata dalla memorialistica dei combattenti: rispetto alla guerra d’Etiopia, uno dei lavori più importanti in questo senso è stato offerto da Nicola Labanca nel 200541.
Il volume, spaziando in ambiti e periodi diversi, dalla storia militare all’espansione coloniale, dal fascismo alla Repubblica, si configura essenzialmente come uno studio pionieristico di un gruppo specifico di memorie, quelle dei combattenti del 1935-’36, delle quali si analizza la progressiva evoluzione, prima durante gli anni fascisti, poi, durante quelli repubblicani.
Quali sono le caratteristiche dello studio di tale memorialistica? Si potrebbe parlare, osserva Labanca, di «un caso di analisi di una “memoria collettiva”», attraverso cui le memorie vengono colte nella loro «essenza prospettica», cioè nel loro conto del presente, che consente «di rileggere e reinterpretare più volte la propria memoria individuale e collettiva42».
In altri termini, in un’analisi della memorialistica edita dai combattenti della guerra d’Etiopia, è necessario tenere presente che la memoria non è mai solo ricordo del passato, ma reagisce al presente; che essa è relazionale nella misura in cui si rapporta al presente e che non è la storia ma ha una sua storia43.
É fondamentale, inoltre, operare una distinzione, all’interno del lavorio della memorialistica, tra coloro che videro la guerra d’Etiopia come un conflitto ideologico e razziale decisivo per l’impero e, quindi, come una guerra del regime, e coloro che invece la affrontarono come “solo” un’altra delle guerre dello stato italiano e, quindi, come una guerra per il regime. Fu per via di quella distinzione, infatti, che nella memorialistica furono attivati dispositivi mnestici, selezionati temi, adottati linguaggi diversi e, soprattutto, cangianti nel corso dei decenni. É necessario sottolineare la rilevanza di tale distinzione dal momento che la memoria agisce sempre in senso selettivo e, quindi, scarta o mantiene ricordi:
[…] il ricordo è sempre selezione – sotolinea Labanca – […] la memoria è intessuta di oblii e […] per poter comporre un’immagine prospettica conforme alla propria soggettività colui che rammenta sceglie accuratamente cosa ricordare. Ed è difficile negare che pubblicando le proprie memorie i singoli combattenti della guerra del regime o della guerra per il regime costruirono due universi per certi versi analoghi ma anche per altri – e su punti importanti – ben distinti44.
Affrontando una serie di problemi metodologici, come l’esistenza o meno di una memoria collettiva, le modalità di formazione di un’identità comune, il rapporto fra la memoria autobiografica e la memoria collettiva, le analisi delle modalità di trasformazione di una memoria e di un’identità, la soggettività delle memorie, Labanca ripercorre l’evoluzione della memorialistica edita sulla guerra d’Etiopia, al fine di capire perché la guerra d’Etiopia sia stata esposta, da un lato, all’oblio, che ha generato a sua volta una pericolosa amnesia auto-assolutoria, dall’altro, ad una memoria fascista, perlopiù rancorosa e inacidita.
Secondo Labanca, l’aspetto più importante dei documenti analizzati è dato dal fatto che essi permettono di smontare l’idea riduttiva della guerra per l’impero come “avventura esotica” e di restituire, invece, la complessità del progetto fascista per l’Etiopia, rivelando quanto poco di questo progetto fosse comune all’esperienza coloniale europea di quel periodo e quanto (tanto) di esso, invece, fosse specificatamente italiano e fascista.
Dalle memorie dei combattenti, edite sotto il fascismo, infatti, emergono alcuni temi ricorrenti, come l’ammirazione della natura africana, osservata perlopiù con meraviglia e stupore, ma anche con desiderio di sfruttamento, conquista e assimilazione: in una parola, di colonizzazione. Altri temi frequenti furono: l’immagine della colonia e dell’Africa in termini di «frontiera»; la prospettiva della guerra di conquista, animata da sentimenti di invasione e appropriazione; il gusto del dominio; la costruzione coloniale dell’Uomo Nuovo e del suo impero; il concetto della razza; l’idea che gli africani fossero solo dei «selvaggi» e che le donne indigene costituissero «un pericolo e una minaccia», per cui ogni comportamento avrebbe dovuto essere improntato ad una distinzione tra elemento bianco ed elemento nativo.
Tutti questi elementi furono ingredienti di una peculiare formula di colonialismo, ben distinta da quella di ogni altro colonialismo dell’epoca, rispetto alla quale il progetto fascista di impero appariva reazionario e particolarmente brutale:
Gli italiani comandano, gli «indigeni» lavorano e ubbidiscono: ecco la formula dell’impero. A chi obiettasse che questa era la formula di ogni colonialismo sfuggirebbe ancora una volta la precisa contestualizzazione cronologica della guerra d’Etiopia: mentre le altre potenze coloniali si ponevano l’obiettivo della valorizzazione e delle autonomie coloniali, mentre il nazionalismo anticoloniale montava e nella lontana India il Partito del congresso di Gandhi aveva dato mostra di organizzare milioni di sudditi coloniali, poco dopo che proprio l’avvio dell’avventura fascista in Etiopia aveva sollevato proteste nei cinque continenti, mentre insomma tutto questo accadeva, il fascismo italiano propagandava il più reazionario ritorno alle sottomissioni del più brutale passato coloniale45.
In un certo senso, l’evoluzione della memorialistica edita riflette un’evoluzione analoga a quella dell’atteggiamento assunto dagli italiani nei confronti del colonialismo: prima il silenzio e il rancore verso la guerra (1945-’65), poi la sublimazione di essa (1965-’85), infine l’analisi tra critica e riabilitazione (1985-2005)46. Per capire le ragioni di tale atteggiamento, si è ricorso talvolta proprio al mito degli «italiani brava gente», che però secondo Labanca non è sufficiente a spiegare silenzi e auto-assoluzioni. Diversi fattori piuttosto hanno concorso ad auto-assolvere gli italiani dalle responsabilità della guerra d’Etiopia: la tragedia della Seconda guerra mondiale; la perdita delle colonie al tavolo della Conferenza di pace; l’assenza di una decolonizzazione classica (come quella francese in Algeria, ad esempio), la mancanza di processi a carico dei sospetti criminali di guerra. In breve, la mancanza di «un dibattito pubblico sul proprio passato coloniale47».
Si è trattato di scelte che hanno avuto conseguenze profondissime sul lungo periodo: esse hanno generato, infatti, una diffusa percezione di impunità che ha favorito il protrarsi di un lungo processo di auto-assoluzione nazionale nonché di taluni atteggiamenti razzisti che avevano nel colonialismo profonde radici.
Molti italiani e molti combattenti del 1935-36 hanno voluto dimenticare o ricordare a proprio modo e a proprio vantaggio la guerra d’Etiopia: per farlo, hanno taciuto o hanno parlato, hanno scritto o riscritto le proprie memorie.
Ogni processo di riscrittura delle memorie e di autoassoluzione dei reduci deve essere spiegato in primo luogo in sé. Ma, come dimostra lo studio della memorialistica del 1935-36, esso avviene in contesti sociali e storici. Poiché l’Italia e gli italiani del dopoguerra repubblicano hanno fatto quasi di tutto per non ricordare il tempo della guerra d’Etiopia, o per ricordarlo a loro esclusivo vantaggio, hanno rischiato e rischiano di rimanere all’interno di una gabbia cui la propaganda di un tempo fornisce ancora alcune fra le sbarre più solide: e più pericolose, ormai anche per il presente48.